L'edicola digitale delle riviste italiane di arte e cultura contemporanea
Juliet Anno Numero 100 novembre 2000
Lars Nittve
Sebastiano Barassi
Intervista al direttore di Tate Modern
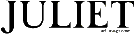
Art magazine
Adrian Paci
Maria Vinella
n. 173 giugno-luglio 2015
Case chiuse, corpi aperti
Roberto Borghi
n. 172 aprile-maggio 2015
Yang Xinguang e la materia
Sara Bortoletto
n. 171 febbraio-marzo 2015
Eugenio Re Rebaudengo
Giulia Bortoluzzi
n. 170 dicembre-gennaio 2015
Biennale Architecture
Gabriele Pitacco Marco Gnesda
n. 169 ottobre-novembre 2014
Biennale Marrakech
Emanuele Magri
n. 168 giugno-luglio 2014



Il 12 maggio 2000, con una copertura mediatica senza precedenti per un'istituzione culturale, è stata inaugurata a Londra la nuova Tate Modern. Il museo, che espone le collezioni moderne e contemporanee della Tate, è ospitato in una centrale elettrica ottocentesca riconvertita sulle rive del Tamigi, nell'area di Bankside. Le collezioni di arte britannica, dal Cinquecento a oggi, rimangono invece esposte nella vecchia sede di Millbank. Dal 1998 direttore di Tate Modern è lo svedese Lars Nittve, laureato in Storia dell'Arte e in Economia, in precedenza curatore al Moderna Museet di Stoccolma, direttore del Rooseum di Malmö e del Louisiana di Humlebaek.
SB: Quali sono le sue impressioni a pochi mesi dall'inaugurazione della nuova Tate?
LN: Il progetto di Tate Modern a cui abbiamo lavorato per oltre otto anni si è rivelato assai più popolare di quanto avremmo mai potuto immaginare. Premesso che non sono un direttore che giudica le attività del proprio museo in termini meramente quantitativi e che, oltre al numero di visitatori, ritengo altrettanto importanti gli aspetti estetici, intellettuali e filosofici di quello che facciamo alla Tate, non posso non sottolineare che, nelle prime sette settimane di apertura, abbiamo avuto un milione di visitatori, una cifra che rappresenta più del triplo delle nostre più ottimistiche previsioni. In questo senso, la mia prima impressione è che possiamo tirare un sospiro di sollievo, perché tutto nell'edificio, dai sistemi di controllo e informatici agli spazi espositivi allo staff, ha retto a questo impatto. In senso più ampio, l'accoglienza di pubblico e critica è stata in generale molto favorevole. I commenti che abbiamo ricevuto riguardano prevalentemente l'architettura e le scelte curatoriali ed espositive. Quasi tutti positivi, ma anche alcune critiche, che ci sono state molto utili per cercare di migliorare quegli aspetti del museo che si sono rivelati più problematici.
SB: Prima di arrivare alla Tate, lei ha lavorato al Lousiana, al Rooseum e al Moderna Museet. Quali influenze sullo sviluppo di Tate Modern hanno avuto queste sue esperienze in Scandinavia?
LN: L'esperienza al Rooseum di Malmoe è, per molti versi, la più simile a questa londinese, anche se su scala decisamente ridotta. Anche lì ho dovuto gestire la conversione di uno spazio industriale in spazio espositivo. Lavorare al Louisiana mi ha permesso di comprendere quanto sia importante, per un museo, focalizzare la propria attenzione sulle esigenze e sui desideri del pubblico - anche se forse lì questo viene fatto un po' troppo. Il fatto che un museo si offra ai visitatori come spazio molto aperto e mosso, immerso nella natura, con percorsi non rigidamente strutturati, fa sì che essi avvertano molto meno il peso dell'istituzione sulle proprie spalle. Questo si rivela estremamente importante per il godimento dell'arte che vi è esposta, anche quando si tratti di arte molto aggressiva e d'avanguardia. E questo stiamo cercando di creare alla Tate, anche se il nostro lavoro è volto a costruire spazi che medino funzionalità espositiva e comfort per il pubblico. Più in generale, comunque, dai miei trascorsi in Scandinavia ho imparato che, per lavorare con l'arte contemporanea, è fondamentale avere un approccio 'informale' ed estremamente flessibile al lavoro museale, essere pronti a cambiare rapidamente strategie e a scavalcare le procedure burocratiche. Questo è un atteggiamento che sto cercando di trasmettere a tutti i miei collaboratori qui alla Tate, e rappresenta uno dei maggiori cambiamenti culturali che mi sono prefisso di imprimere: agire con maggiore agilità, come una Kunsthalle più che come un museo nazionale in senso classico, senza però dimenticare che è innanzitutto quest'ultimo quello che noi siamo.
SB: L'edificio di Tate Modern è assolutamente imponente, e rappresenta uno straordinario salto in avanti in termini di spazio rispetto al museo a cui tutti noi siamo abituati. Non pensa che si corra il rischio che la straordinarietà dell'architettura in qualche modo faccia passare in secondo piano le opere che vi sono esposte - un po' come avviene, ad esempio, al Guggenheim di Bilbao?
LN: All'inizio è quasi inevitabile che sia così, per chi viene per la prima volta l'attenzione si focalizza quasi esclusivamente sull'edificio. L'effetto sorpresa per chi entra nella Turbine Hall è ovviamente molto forte, e lo stesso vale un po' per tutto l'edificio. Ma poi penso sia inevitabile che i visitatori si rendano conto che questo non è che un palcoscenico sui cui si muovono le opere. E, d'altro canto, una volta entrati nelle gallerie, gli spazi espositivi sono tutto sommato convenzionali, anche se di altissima qualità e funzionalità, nella loro semplicità.
SB: Non pensa, però, che trasformare uno spazio industriale di così grande carattere in uno spazio espositivo tutto sommato convenzionale, un white cube, sia in qualche modo un'operazione contraddittoria? Non ritiene, cioè, che piuttosto che inseguire un'illusoria e irraggiungibile neutralità dello spazio espositivo, sarebbe stato più stimolante cercare di esporre le opere in un contesto così fortemente caratterizzato?
LN: Ci sono due risposte alla sua osservazione. Innanzitutto l'edificio in sé, quando è entrato in nostro possesso, era un contenitore vuoto, di integro c'erano solo i muri perimetrali, per cui, in realtà, l'interno lo abbiamo dovuto creare dal nulla: si tratta, a tutti gli effetti, di un nuovo edificio entro una vecchia armatura. L'alternativa sarebbe stata la creazione di interni in stile industriale, che abbiamo ritenuto un approccio sbagliato. Invece di inseguire un romantico gusto industriale, Herzog e de Meuron (gli architetti incaricati della trasformazione della vecchia centrale elettrica in museo, ndr) hanno creato un edificio in cui la ruvidezza della struttura industriale si sposa con l'eleganza canonica del museo di belle arti. Mentre installavamo la collezione, ci siamo resi conto che questo equilibrio ci permette di sfruttare entrambe queste caratteristiche a seconda della natura dell'opera da installare. L'esempio che mi viene in mente è quello di una sala in cui originariamente avevamo esposto un'installazione molto funky e 'difficile' di Matthew Barney e che, successivamente, abbiamo deciso di dedicare a quadri più classici di Picasso e Braque. La stessa sala, a seconda di cosa vi era esposto, dava sensazioni spaziali e percettive radicalmente diverse, e questa flessibilità ritengo sia uno dei maggiori pregi di questo edificio.
SB: Una delle differenze principali, fra le istituzioni in cui ha lavorato in passato e la Tate, è ovviamente la composizione del pubblico, in senso sia numerico sia qualitativo. Qual è la sua percezione del visitatore della Tate ?
LN: In termini di età e sesso, il pubblico della Tate è sostanzialmente rappresentativo dello spettro sociale britannico. In termini socio-economici, invece, nonostante alcuni sforzi fatti negli ultimi 5-10 anni (per esempio attraverso la selezione degli artisti per il Turner Prize, sempre più orientata a favorire artisti provenienti da minoranze etniche, ndr), la stragrande maggioranza del nostro pubblico è costituita da bianchi di classe media. La nuova sede di Bankside, tuttavia, forse perché percepita dal pubblico come uno spazio di intrattenimento in senso più ampio, o forse solo per una questione di moda - è ancora presto per fare delle valutazioni complessive - sembra, per il momento, attrarre una sezione più ampia dello spettro sociale. In questa direzione stiamo anche collaborando con le autorità locali, per far sì che Tate Modern sia percepita dai residenti non solo come un museo nazionale ma anche come un'istituzione 'di zona'. Io sono fortemente convinto dell'importanza che la comunità locale ci percepisca come parte di sé, e non come un'entità aliena, un'attrazione solo per turisti.
SB: Si diceva prima che la sua idea di Tate è una via di mezzo fra il museo nazionale di arte moderna e la Kunsthalle. Come pensa di ottenere questo equilibrio fra esigenze tanto differenti?
LN: Uno degli aspetti più eccitanti del progetto Tate Modern è il fatto che, sin dal suo inizio, siamo stati costretti a metterci in discussione e riflettere sulla nostra identità, come istituzione e come individui. Questo ci ha portato a interrogarci su tutti gli aspetti del nostro lavoro e del nostro ruolo sociale e culturale. Sapevamo sin dall'inizio di dover essere un museo nazionale di arte moderna. Ma in che senso? Abbiamo sempre pensato di volerlo essere nel senso più solido e classico, con una forte componente di ricerca accademica, mostre monografiche accuratamente preparate e prestiti di altissima qualità, un'istituzione come il MOMA o il Centre Pompidou, per intenderci. Allo stesso tempo, però, volevamo alzare il tiro, tentare nuove vie. Per fare ciò siamo partiti passando in rassegna i classici grandi musei di arte moderna nel momento del loro massimo splendore e di maggior interazione col tessuto sociale - il MOMA degli anni Quaranta e Cinquanta, il Moderna Museet negli anni Sessanta, lo Stedelijk degli anni Cinquanta e Sessanta, per esempio - cercando di capire da dove questo successo derivasse. Ciò che abbiamo scoperto è che, in tutti i casi studiati, ricorrevano un grande senso di urgenza e una enorme consapevolezza dell'importanza di ciò che si stava facendo a ogni livello, senza dare priorità particolari, ma trattando l'arte contemporanea alla stessa stregua di quella più classica. In secondo luogo, in questi musei tutto il materiale esposto veniva consapevolmente presentato attraverso un'ottica contemporanea, senza tentativi di storicizzazione e oggettività. L'entrata del mercato dell'arte nella sua era moderna e la scoperta della deteriorabilità delle opere dell'ultimo secolo, con la conseguente tendenza a ridurne i prestiti, fecero sì che questo approccio lentamente si modificasse. Si cominciarono a creare gerarchie che, poco alla volta, condussero i musei di arte moderna a privilegiare l'arte 'classica' a scapito di quella contemporanea. Questi sono stati alcuni dei fattori di cui abbiamo tenuto conto nello sviluppo della nostra politica espositiva. E siamo arrivati a elaborare un sistema che comporta un museo operante su due livelli: da un lato lavoriamo su progetti a lunga scadenza - una mostra monografica su un artista come Picasso, per esempio, che richiede circa sei anni di preparazione -, dall'altro portiamo avanti progetti più agili, che richiedono meno lavoro di ricerca accademica e privi di complicazioni burocratiche, lavorando a stretto contatto con gli artisti, come fanno istituzioni più piccole come le Kunsthalle. Questa è la nostra idea, ora finalmente sperimenteremo sul campo se può funzionare.
SB: Iwona Blazwick, responsabile dell'interpretazione delle collezioni, a un convegno dello scorso anno citò numerose possibilità espositive (esposizione delle opere per nuclei tematici; per diversità di influenze culturali; per modalità di produzione e fruizione - biennali, Documenta, Mostra dell'Arte Degenerata, collezionismo privato etc; per influenze socio-politiche; per centri di produzione - Parigi, Berlino, Londra, Milano etc. ). La certezza da cui siete partiti, comunque, è la necessità di trovare un'alternativa alla esposizione in ordine cronologico e per scuole nazionali, come una singola narrazione.
LN: I motivi per cui volevamo liberarci di questo schema espositivo erano molteplici: alcuni ideologici, altri legati allo spazio espositivo, altri ancora relativi alla natura della collezione.
Sin dall'inizio del nostro lavoro teorico, siamo stati convinti che non è più realistico pensare che esista, in un museo come in un libro, un'unica, 'vera' storia dell'arte moderna. Siamo partiti dal presupposto, dunque, che ci siano molteplici storie, tutte di pari dignità e interesse, e che una stessa opera può recitare ruoli diversi in diverse narrazioni. Tra l'altro, quando abbiamo discusso il nome da dare al museo, ci siamo interrogati se chiamarlo Tate Modern o Tate Modern and Contemporary, e siamo arrivati alla conclusione che è solo considerando l'arte dell'ultimo secolo entro un'ottica evoluzionistica che si arriva a percepire una cesura fra arte moderna e contemporanea. A un'analisi approfondita, tuttavia, non si può dire che esistano differenze sostanziali fra l'approccio estetico di Marcel Duchamp e quello di Damian Hirst. Con le nostre scelte espositive, dunque, intendiamo sottolineare che non ha più senso chiamare Duchamp 'moderno' e Hirst 'contemporaneo'. Quello che ci prefiggiamo, in ultima analisi, è raccontare diverse storie dell'arte dell'ultimo secolo, e proporre nuovi modi di guardare alle opere. Altrettanto forte è la nostra convinzione della necessità di liberarci di certe categorie storiografiche - quali, ad esempio, 'minimalismo' - che non aiutano in nessun modo una reale comprensione dell'opera, e che sono spesso state rifiutate dagli stessi artisti in esse collocati. C'è, poi, la considerazione che tutti noi volevamo rompere con gli schemi espositivi tradizionali, in particolare con l'ordinamento cronologico delle opere. Questo per varie ragioni. Innanzitutto il fatto che questo approccio nasce negli anni Trenta con Alfred Barr (il direttore del MOMA che ideò un unico grafico in cui categorizzare e collegare tutti i movimenti dell'arte del Novecento, ndr), quando la storia dell'arte moderna copriva un arco di 30 o 40 anni, mentre ora essa è di 70 anni più lunga. Museologicamente, questo tipo di narrazione porterebbe a un percorso insopportabilmente lungo. Allo stesso tempo, tale percorso si rivelerebbe a-storico, perché il visitatore si troverebbe di fronte sale monografiche che rappresenterebbero unità a sé stanti, senza alcun senso dello sviluppo storico di più ampio respiro di molte poetiche e tematiche. Paradossalmente, perciò, abbiamo voluto rompere con l'esposizione cronologica per riportare la storia nel museo. Uno dei metodi che abbiamo seguito, ancora una volta, è stato lo studio di istituzioni come lo Stedelijk, il Moderna Museet, il Walker Art Centre, il Museum of Modern Art di San Francisco che hanno già tentato nuovi approccio all'esposizione delle loro collezioni, ricorrendo all'uso di nuclei tematici e ad accostamenti di opere in contrapposizione. Non tutti gli esempi che abbiamo studiato erano felici: i rischi più comuni che abbiamo identificato erano la creazione di contrapposizioni artificiose, per il solo gusto dell'effetto; il fatto che le sale potessero risultare tutte troppo simili; la mancanza di chiarezza dei legami fra le opere accostate, che rischiano di essere troppo oscuri ed enigmatici. Muovendo da queste considerazioni, dunque, alcune delle possibilità che lei ha citato ci sono presto apparse impraticabili. La scelta, alla fine, è caduta sull'esposizione per quattro ampi nuclei tematici (storia/memoria/società, natura morta/oggetto/vita reale, azione/corpo/nudo, paesaggio/materia/ambiente, ndr) che rispecchiano, in fondo, le quattro tradizionali categorie accademiche in cui viene suddivisa l'arte. Uno dei motivi che ci hanno spinto in questa direzione è stata la conferma, venuta dagli artisti che abbiamo interpellato, che queste sono tutte categorie di cui essi tengono, più o meno coscientemente, conto quando creano le proprie opere. E questo radicamento nella pratica artistica era un elemento a cui tenevamo particolarmente. Altrettanto importante, nella nostra scelta, è stato il fatto che queste categorie ci permettono di suddividere la collezione in quattro porzioni di dimensioni e qualità sostanzialmente simili: questo ci consente di avere nel museo quattro narrative dello stesso peso e parallele, senza che nessuna di queste prevalga, quantitativamente o qualitativamente, sulle altre. All'interno di questa struttura abbiamo cercato di creare una certa varietà, di rompere il ritmo espositivo, per esempio creando sale monografiche, e di non essere rigidi nelle scelte, di non cadere nella trappola della coerenza a tutti i costi. Sulla scelta finale ha avuto il suo peso anche la considerazione che la disposizione architettonica delle sale (organizzate su due piani, ciascuno suddiviso simmetricamente in due) sembra quasi invocare la presenza di quattro diverse narrazioni. C'era, infine, la questione della natura della collezione, che non è stata assemblata, come ad esempio al MOMA, per illustrare lo sviluppo storico dell'arte moderna nella sua completezza. Le politiche di acquisizione dei vari direttori del passato sono state molto varie - alcuni di essi detestavano l'arte moderna, e non va dimenticato che la Tate Gallery fu fondata per essere la Galleria Nazionale di Arte Britannica. Questi elementi hanno come conseguenza che ci siano diverse aree deboli nella collezione, un fatto che, anche se lo volessimo, non ci permetterebbe di proporre un percorso storico completo. Abbiamo, perciò, deciso di raccontare le storie che possiamo raccontare meglio.
A cura di Sebastiano Barassi


